Paolo Galiano (a cura di), Raimondo Gaufredi. Trattato del leone verde (De leone viridi): dal ms 433 Helmst di Wolfenbüttel, postfazione di Massimo Marra (Nuova Biblioteca Ermetica, 4), Edizioni Mediterranee, Roma 2020, pp. 125, Euro 22,00.
Per gli alchimisti la prima materia è il Caos primigenio oggetto della manipolazione, il corpo minerale che privo di vita giace nel fondo dell’«Ade».
Tale massa cadaverica è rianimata grazie all’acqua «divina», che per un gioco di parole possibile solo in greco è anche un’«acqua sulfurea». Tale acqua miracolosa è la rugiada che discende dal «cielo», cioè defluisce dall’alto dell’alambicco oppure dalla kērotakis, uno strumento derivato dalla tavolozza riscaldata impiegata nella tecnica pittorica dell’encausto, formato da un vaso chiuso in cui i fogli di metallo erano sottoposti all’azione colorante dei vapori circolanti al suo interno. Nell’acqua è racchiusa una forza trasmutativa, lo «Spirito di luce» capace di tingere e «colorare» i metalli. L’operazione mette in fuga lo «Spirito di tenebra», ovvero provoca una mutazione sostanziale all’interno del nero e maleodorante agglomerato metallico, arrecando nuova vita e un intenso, rilucente colore bianco. Il sorgere di questo «nitore» o «biancore» annuncia il ritorno dell’«anima» nel corpo. La comparsa del biancore argenteo nel metallo rigenerato non è l’ultima tappa nel processo trasmutativo: la fase successiva è l’unione, figurata in termini sessuali, tra lo sposo (il corpo) e la sposa (l’anima). Le conseguenze di tale matrimonio alchemico sono una ulteriore mutazione di colore nella massa metallica, che da bianca diventerà gialla, poiché in essa si rivela lo «spirito aureo», dapprima celato nell’acqua divina e sulfurea e ora eiaculato e permeante l’anima. La rivivificazione e la rigenerazione del corpo è quindi descritta nei termini di una mistica nuziale, in cui il corpo, l’anima e lo spirito si congiungono indissolubilmente, diventando un tutt’uno per sempre; un’unione che non è un semplice mescolamento di elementi separabili, ma una henōsis, una «coesione», una assimilazione dei tre componenti l’essere umano. L’unione degli opposti è il fondamento del mysterium coniunctionis alchimico, plasticamente figurato in una svariata serie di miniature e testi a stampa, anche in termini palesemente espliciti, come nel caso del più famoso testo alchemico attribuito al medico francescano Arnaldo da Villanova, il Rosarium philosophorum.
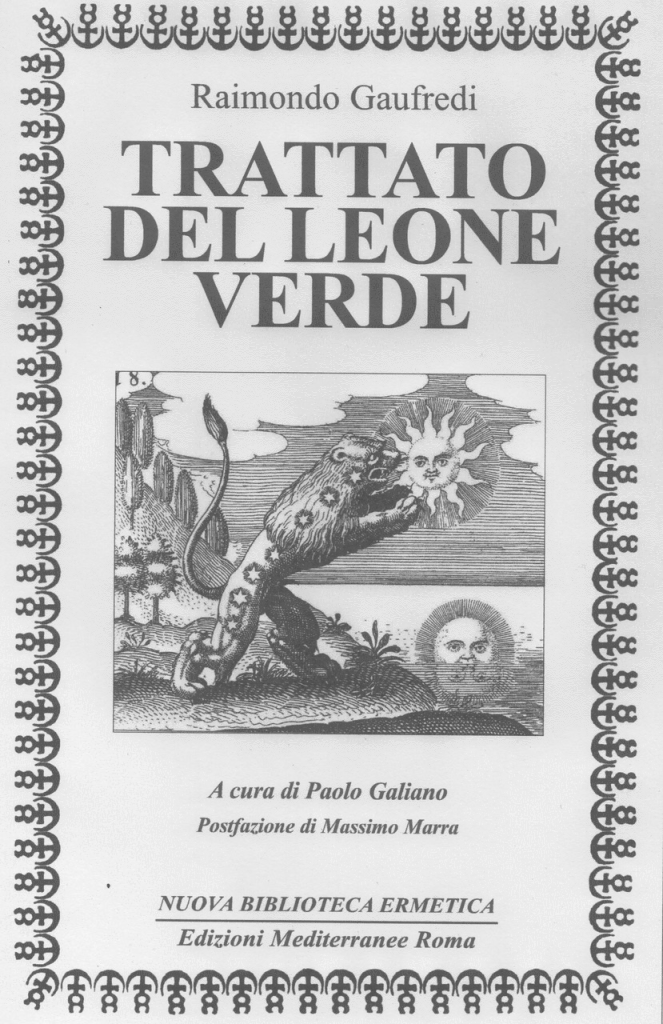 All’ambiente francescano è da ascrivere anche la figura di Raimondo Gaufredi (†1310), ministro generale dell’Ordine a cui vennero ascritte svariate opere alchemiche. Una tradizione che risale a una delle figure più note del primo francescanesimo, Frate Elia da Cortona (1170/1180 ca.-1253), ritenuto autore di un testo alchemico intitolato Lumen luminum, che avrebbe scritto alla corte di Federico II dopo esser stato cacciato da ministro generale dell’Ordine francescano nel 1239. Su questo vedasi il vetusto lavoro di Mario Mazzoni, Sonetti alchemici di Cecco d’Ascoli e frate Elia, Casa Editrice Toscana, San Gimignano 1930 (poi Atanòr, Roma 1955); un testo che trova il suo completamento nell’opera di Paolo Galiano, uno studioso che a Frate Elia ‘alchimista’ ha dedicato una vera e propria pletora di saggi (Il Pretiosum donum Dei, Simmetria, Roma 2017; Lo Speculum alchimiae di Frate Elia, Simmetria, Roma 2018; L’opera alchemica in frate Elia, con Anna Maria Partini (Biblioteca Ermetica, 33), Edizioni Mediterranee, Roma 2018; Il magisterio della pietra filosofica. I quattro gradi del fuoco nella pratica alchemica, Simmetria, Roma 2018), rivelando un interesse che lambisce i limiti dell’ossessione ermetica.
All’ambiente francescano è da ascrivere anche la figura di Raimondo Gaufredi (†1310), ministro generale dell’Ordine a cui vennero ascritte svariate opere alchemiche. Una tradizione che risale a una delle figure più note del primo francescanesimo, Frate Elia da Cortona (1170/1180 ca.-1253), ritenuto autore di un testo alchemico intitolato Lumen luminum, che avrebbe scritto alla corte di Federico II dopo esser stato cacciato da ministro generale dell’Ordine francescano nel 1239. Su questo vedasi il vetusto lavoro di Mario Mazzoni, Sonetti alchemici di Cecco d’Ascoli e frate Elia, Casa Editrice Toscana, San Gimignano 1930 (poi Atanòr, Roma 1955); un testo che trova il suo completamento nell’opera di Paolo Galiano, uno studioso che a Frate Elia ‘alchimista’ ha dedicato una vera e propria pletora di saggi (Il Pretiosum donum Dei, Simmetria, Roma 2017; Lo Speculum alchimiae di Frate Elia, Simmetria, Roma 2018; L’opera alchemica in frate Elia, con Anna Maria Partini (Biblioteca Ermetica, 33), Edizioni Mediterranee, Roma 2018; Il magisterio della pietra filosofica. I quattro gradi del fuoco nella pratica alchemica, Simmetria, Roma 2018), rivelando un interesse che lambisce i limiti dell’ossessione ermetica.
Frate Elia o Elia da Cortona è certamente una presenza importante, poiché succede a san Francesco d’Assisi quale ministro generale dell’Ordine dei Frati minori nel 1226. Ha reputazione di alchimista e come tale è citato nella Ars alchemie di Michele Scoto. Ai giorni nostri possediamo un buon numero di opere alchemiche che portano il suo nome. I sonetti stampati a Venezia nel 1475 in sincronia con le opere di Geber (Jābir ibn Ḥayyān). Un De lapide philosophorum edito a Francoforte nel 1685 e una serie di manoscritti datati tra il XIV e il XV secolo: a Londra (BL, Sloane 692; BL, Sloane 3457), Roma (BAV, Pal. lat. 1267; BAV, lat. 4092), Palermo (B. Comunale, 4Qq A10), Parigi (BN, Nouv. acq. lat. 1293) e Bologna (B. Univ., lat. 138 [104]). Tutti questi testi sono analizzati e presentati nelle opere del Galiano. Notevole è quindi l’influsso esercitato dall’alchimia nel monachesimo francescano; se Elia da Cortona è il primo celebre esempio, seguiranno tre notevoli alchimisti: Ruggero Bacone, il citato Arnaldo da Villanova e Giovanni di Rupescissa. In questa tradizione si colloca anche il De leone viridi, che il Galiano presenta e commenta in questo suo ultimo libro. L’accenno che si è fatto all’inizio circa il parallelismo fra pratica alchemica e immaginario erotico non è portato a caso: oltre al Rosarium fraudolentemente attribuito ad Arnaldo da Villanova, anche gli pseudoepigrafi di Frate Elia sono densi di figurazioni chiaramente sessualizzate, dove il simbolismo dei corpi si unisce a quello della reciproca interazione dei fluidi fisiologici: ognuno crede di avere una volontà e di saperla adoperare a proprio beneficio, ma, per citare un ermetista nostrano come Giuliano Kremmerz: «Vi prego di ricordare bene, perché tutto il simbolismo alchimico è un tessuto fittissimo di rapporti etimologici, analogici, e omologici. Più la nostra cultura sociale diviene vasta ed enciclopedica e meno la gente capisce quel linguaggio alchimico... Due sono le facce dell’esposizione alchimica: mutare i metalli volgari e di poco prezzo in oro, e trasmutare l’anima vile e volgare dell’uomo in spirito (soffio) divino...» (La Scienza dei Magi, III: Dialoghi sull’Ermetismo e scritti minori, Edizioni Mediterranee, Roma 1975, p. 139). Sembra quindi abbastanza logico che il codificare pratiche oggettivamente incompatibili con la pietas pandemica del tempo condurrà, tra la fine del XIII e la metà del XIV sec. la disciplina alchemica incontro ad accese polemiche e condanne da parte di vari ordini religiosi. Un ulteriore mutamento si avrà tra la fine del XIV e il XV sec. che vedrà una grande proliferazione di trattati alchemici, tra i quali figureranno anche commenti, dossografie e compilazioni; molti di questi testi verranno redatti non in latino, ma nelle diverse lingue volgari: l’alchimia non soltanto penetrerà nella cultura generale del pubblico non specializzato, ma inizierà ad essere praticata in ambienti molto diversi da quelli a cui in origine era destinata.
Ezio Albrile




![Raimondo Gaufredi. Trattato del Leone Verde [De leone viridi] (di E. Albrile)](/images/2021/07/25/1202_TrattatoLeoneVerde.jpg)
