L’opera di Attilio Mordini (1923-1966) solo dopo la sua scomparsa ha iniziato a trovare il posto che le spetta nell’àmbito della cultura tradizionale: la maggior parte dei suoi lavori, rimasti inediti durante il periodo della sua breve vita, sono comparsi postumi, testimoniando l’interesse crescente verso un autore che Franco Cardini e Mario Bernardi Guardi chiamano Maestro con la maiuscola[1]. Un interesse, si badi bene, da parte sia dei suoi fautori, quanti riconoscono in lui uno dei principali interpreti italiani della Tradizione, sia dei suoi detrattori di destra e di sinistra, i quali mettono in rilievo i difetti e gli errori del suo pensiero, ovviamente non consono al loro[2].
Con questo breve ricordo vogliamo dare il nostro contributo alla conoscenza di un autore che fu al tempo stesso cattolico fervente e uomo della Tradizione, capace di ritrovare nel pensiero cristiano quella sapienza che, come scrivono Ireneo[3] e S. Agostino[4], prima che il Figlio di Dio si incarnasse già era conosciuta dai saggi del tempo antico di ogni civiltà e di ogni tempo, quella philosophia perennis che Marsilio Ficino ed Egidio da Viterbo recuperarono nel ‘400 esponendola nei loro scritti. È il Verbo il filo conduttore che lega le religioni antiche con il cristianesimo: “Già nei tempi precristiani le religioni tramandavano il ‘tipo’ della Parola divina e del divino commercio tra la divinità e l’uomo”[5].
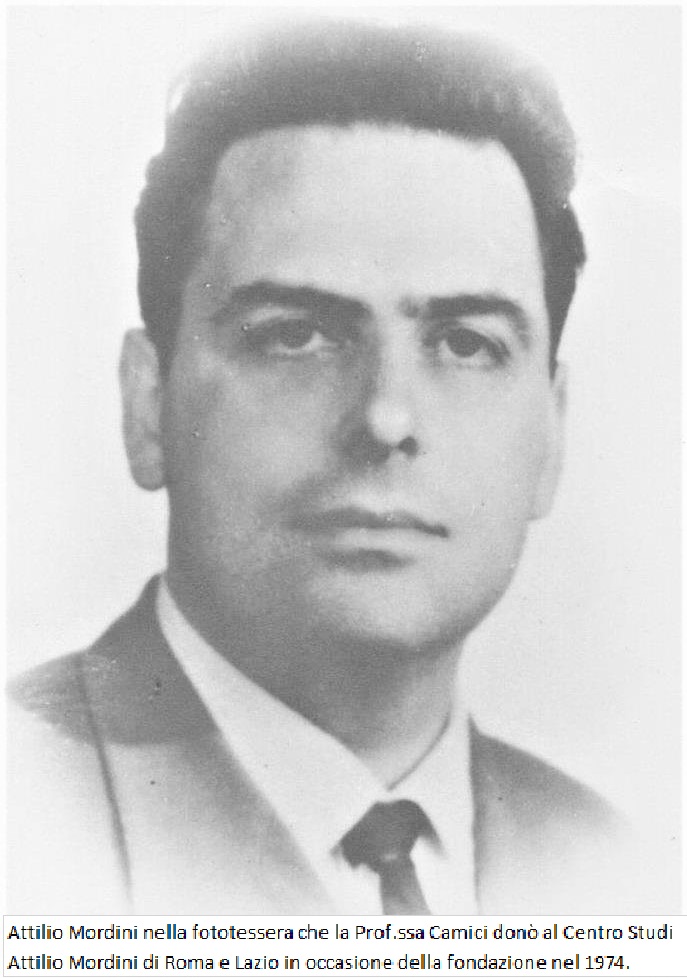 LA VITA
LA VITA
Attilio Mordini nasce a Firenze il 22 Giugno del 1923 e vi muore il 4 Ottobre 1966, giorno di S. Francesco, lui che era Terziario francescano con il nome di fra’ Alighiero, e un mese prima della nota e triste alluvione di Firenze.
Dopo aver studiato nelle scuole cattoliche degli Scolopi e dei Salesiani, allo scoppio della II Guerra Mondiale Mordini si arruola volontario e viene inviato a Genova presso la Terza Legione Antiaerea; nel Settembre del 1943, dopo l’armistizio, entra come guastatore nella IV Divisione dei Panzer Pionier agli ordini del maggiore Lindbergh che operò in Ucraina. Bernardi Guardi, il quale attinge ai ricordi della professoressa Maria Camici[6], discepola di Mordini, riferisce che riuscì ad arruolarsi nel 1940 non ostante una zoppia conseguente a un incidente tranviario subìto all’età di quindici anni.
A causa di un congelamento ai piedi[7] viene rimpatriato in Italia, entra nell’Ufficio Stampa della MVSN della RSI, viene catturato dagli americani nel 1945 e imprigionato a Belluno; dopo la scarcerazione viaggia per l’Italia fermandosi in particolare a Roma, dove divenne segretario di padre Alighiero Tondi S. J. (poi divenuto ateo e passato nelle file del PCI), ma è arrestato dalle autorità italiane con l’accusa di aver militato nelle forze della RSI, processato e incarcerato alle Murate di Firenze, dove contrae quella tubercolosi che lo porterà alla morte.
Foto: Attilio Mordini nella fototessera che la Prof.ssa Camici donò al Centro Studi Attilio Mordini di Roma e Lazio in occasione della fondazione nel 1974.
Dopo la scarcerazione si iscrive alla Facoltà di Magistero di Firenze, ove consegue la laurea in lingue straniere grazie alla quale diventerà più tardi lettore di lingua italiana all’Università di Kiel in Germania, ma soprattutto inizia a frequentare gli ambienti cattolici della città, facendo amicizia con personaggi della sua stessa fede politica ma anche di pensiero opposto, da don Divo Barsotti a padre Balducci e padre Turoldo, da Giorgio La Pira a Fausto Belfiori, Paolo Caucci, Primo Siena, Franco Cardini, Giovanni Cantoni; il conte Neri Capponi metterà a disposizione di questo “cenacolo” la cappella sconsacrata di San Tommasino in via della Pergola di sua proprietà per le loro riunioni del giovedì[8].
Alimenta questa sua attività intellettuale con l’incessante ricerca spirituale e interiore, che rafforza con pellegrinaggi e periodi di ritiro presso il monastero francescano della Verna (il rapporto con la figura di San Francesco è uno dei cardini del suo pensiero[9]) per seguire quella sua vocazione di seguace non solo a parole di un cristianesimo mistico e militante che va sempre più scomparendo diluendosi in un ecumenismo globalizzato e buonista. Le sue parole ne Il Tempio del cristianesimo sono illuminanti: “Vita militia est aveva scritto San Paolo … ciascun cresimato è milite nel mondo per le armi o nel chiostro per la penitenza e la contemplazione”[10].
A causa delle complicanze della tubercolosi contratta durante il periodo del carcere, non ostante le cure, Attilio Mordini si spegne a Firenze il 4 Ottobre del 1966.
LE OPERE
Ricca la sua attività di scrittore: collabora tra il 1958 e il 1966 con numerosi articoli che spaziano dalla mistica alla storia, dal simbolismo all’analisi delle opere di personaggi quali il poeta tedesco Stefan George e Teilhard de Chardin sulle riviste tradizionalista fondate dai suoi conoscenti e amici, quali L’Ultima fondata da Giovanni Papini a Firenze e diretta da Adolfo Oxilia, Il Carattere di Primo Siena a Verona, Adveniat Regnum di Fausto Belfiori a Roma, Il Ghibellino di Giovanni Allegra a Messina e L’Alfiere di Silvio Vitale a Napoli, tutte riviste a cui Mordini collaborerà con i suoi articoli, che vennero anche pubblicati su Kairos dei Benedettini di Salisburgo, diretta da Mathias Vereno, e Antaios, fondata a Stoccarda da Ernst Jünger e Mircea Eliade.
Numerosi sono i libri da lui scritti, ma solo quattro sono stati pubblicati prima della sua morte: Il segno della carne (con lo pseudonimo di Ermanno Landi, La Fronda Editrice, Firenze 1959), Il tempio del cristianesimo (Edizioni CET, Torino 1963), Giardini d’Oriente e d’Occidente (in collaborazione con Pietro Porcinai, Fratelli Fabbri Editori, Milano 1966) e Dal mito al materialismo (Il Campo, Firenze 1966). Tutte le altre opere da lui scritte sono comparse postume, a partire da Verità del linguaggio (con prefazione di p. Raimondo Spiazzi, Volpe, Roma 1974) fino al recente INRI. Il mistero del Regno (Cantagalli, Firenze 2021).
IL PENSIERO
Il pensiero che Mordini espone nelle sue opere è complesso, estendendosi a tutti i campi in cui si realizza l’uomo nella sua integralità. La sua posizione di ghibellino e di cattolico militante e la sua conoscenza della storia antica e contemporanea, della teologia e della mistica cattolica, dei miti, delle fiabe (alla cui interpretazione Mordini dedica la prima parte del testo Dal mito al materialismo) e delle civiltà precristiane gli consentì di tenersi distante dai due estremi del progressismo cattolico che al suo tempo andava diffondendosi con sempre maggiore virulenza e dalle estremizzazioni politiche e ideali della frangia neopagana della Destra, consentendogli così di farsi nemici dall’una e dall’altra parte.
Il fondamento ideale del pensiero mordiniano è cattolico e metafisico e si incentra nell’Incarnazione del Verbo che da sempre si esprime in tutte le opere dell’uomo dando ad esse un significato che va oltre il senso materiale; il mito, nel senso proprio del termine, come la fiaba sono lo strumento per penetrare questo mistero del rapporto tra l’Incarnazione del Verbo e il mondo dell’uomo, mistero da cui l’uomo moderno si sta sempre più allontanando a favore di una visione scientista e razionalista che lo aliena dalla Realtà.
La storia, andando oltre le concezioni meccanicistiche ed economicistiche da un lato e quelle psicologistiche dall’altro, è riportata a una dimensione sovratemporale, inquadrando gli eventi nella curva che passa per i tre punti-chiave del tempo, la Creazione, la Redenzione e la Parusia[11], da leggere con i quattro sensi danteschi: “Cercare il significato della storia è come esaminare un testo nella sua lettera per considerarne poi il senso anagogico ... la storia è quindi struttura di simboli viventi ordinati alla tradizione sacra della Rivelazione”[12]; la politica ha il suo naturale centro nella concezione ghibellina dell’Impero e del Cavaliere, che dell’Impero costituisce la naturale estensione nell’affermazione dell’ordine e della giustizia[13] e la famiglia è il nucleo fondamentale dell’ordinamento civile: “Come nell'unità cattolica si distinguono e si ordinano le nazioni, così la famiglia trova la sua espressione più alta quale fondamento naturale d'ogni istituzione civile”[14]. Il lavoro è “nel suo senso più profondo di contatto con la realtà e quindi dialogo amoroso dell’uomo e delle creature in Dio”[15] per conservare e perfezionare la creazione; la cultura, che Mordini mette in relazione tramite la radice *kwel con la parola “culto”[16]; l’arte, arte figurativa come teatrale[17], è “ordine”, dalla radice *rta, e quindi ha un valore sacrale ed è strumento per partecipare alla lotta del Cosmos contro il Chaos, ben lontana da certe oscenità dell’arte moderna esaltate da pseudocritici cervellotici.

Dante e Beatrice davanti all’Aquila della Giustizia (Paradiso c. XIX - ms Yates-Thompson 36, London, British Library, redatto nel 1444-1450, c. 130r).
Come si vede, riassumere in un articolo il complesso significato dell’opera di Mordini non è possibile, per cui concludiamo riportando un brano da un testo comparso esattamente cinquant’anni fa nel 1973[18], dal titolo Tradizione e Restaurazione, saggio introduttivo al pensiero di Attilio Mordini, scritto dal Centro Studi Mordiniani di Roma e pubblicato per pochi amici e conoscenti con il ciclostile (altri tempi, altro che Facebook, web e chat!), il primo lavoro in cui è stato presentato in modo globale il pensiero di Mordini sulla Tradizione dell’Occidente.
Non vi è dubbio che in questo momento l'Europa stia precipitando nell'abisso di una profonda crisi da cui non sembra facile trovare una via d'uscita. È forse la prima volta che in Occidente la crisi assume una portata di dimensioni tali da investire non un solo aspetto della personalità umana, ma ogni sua espressione: dalla politica alla religione, dal lavoro all'arte, dalla filosofia all'economia.
Sotto l'apparenza del benessere e della tranquillità economica le popolazioni più ricche sono atterrite dalla “paura del domani”. Come osserva Mordini, “la frase evangelica ‘Non preoccupatevi del domani’ viene diabolicamente invertita: si evita di pensare al domani non per fiducia verso Dio, ma per disperazione. L'avvenire incute timore non in quanto ignoto, ma in quanto certo e ineluttabile. I dirigenti delle nazioni appaiono impegnati nel tentativo di procrastinare una catastrofe che sentono quasi inevitabile”[19].
È tempo di crisi, e crisi, dal greco krinos, vuol dire giudizio; dobbiamo quindi giudicare questo mondo per scoprire l'origine della sua decadenza. “Se vogliamo dare un giudizio sereno sulla storia dell'occidente e fare il punto sulla condizione in cui versa la nostra civiltà, ci si deve attenere a misure trascendenti la stessa storia e il tempo. Il giudizio è parola, è Verbo e senza Verbo i fatti restano muti”[20]. Appare così in tutta la sua evidenza la radice della crisi: è l’assenza del verbo nella civiltà, assenza voluta da un tipo umano che cerca di abolire il Sacro dalla sua esistenza. È la prima ed unica eresia, è il non serviam di Lucifero che sprezzantemente viene scagliato contro Dio: non serviam all'autorità spirituale, non serviam al potere temporale di diritto divino.
Questa eresia, sviluppatasi e affermatasi nel passare dei secoli fino a compenetrare intimamente la natura dell'uomo moderno, procede a sua volta dall'atto superbo con cui l'uomo si è posto come individuo, come entità dichiaratamente separata da Dio, come quantità che si oppone alla qualità. Contemporaneamente “negata la misura dell'Uomo Universale (cioè il Verbo in quanto Dio-uomo) è perduto il canone del Tempio ed è perduto ogni valore della persona umana”[21]. Volendo annullare Dio, l'uomo è riuscito invece a distruggere se stesso sul piano spirituale e intellettuale; per quanto riguarda poi il piano materiale, i mezzi per poterlo fare sono di giorno in giorno in via di perfezionamento.
Ricordiamo le parole con cui Mordini chiude il suo Tempio del Cristianesimo: “Solo agli uomini di buona volontà il Cielo promette quella pace che è vittoria finale e trasfigurazione dell’universo”[22].
[1] Mario Bernardi Guardi, Le opere e i giorni di Attilio Mordini, con La testimonianza di Franco Cardini in appendice, in “Abstracta”, 17 (1983), pp. 58-64.
[2] Ancora nel 2020 si possono leggere lavori di questo argomento, non ultimo La distruzione quasi totale dell’umanità: Attilio Mordini e la crociata atomica pubblicato il 9 Aprile 2020 da un “Mister Totalitarismo” volutamente anonimo, come afferma lo stesso autore sotto la voce “Contatti” del suo sito.
[3] Ireneo, Adversus haereses IV, 6-7: “Dall'inizio infatti il Figlio stando a fianco delle sue creature rivela a tutti il Padre, a chi vuole, quando vuole e come vuole; perciò in tutti e operante dappertutto v'è un unico Dio ed un unico Verbo Figlio ed un unico Spirito”.
[4] S. Agostino, Retractationes I, 13: “Quella che si chiama ora religione cristiana esisteva già presso gli antichi: non è venuta mai meno al genere umano dagli inizi fino all'Incarnazione di Cristo, dopo la quale la vera religione, che esisteva già prima, cominciò ad essere chiamata cristiana”.
[5] Attilio Mordini, Il Tempio del Cristianesimo, Centro Editoriale Torinese, Torino 1963, p. 57.
[6] Maria Camici ha pubblicato insieme a Franco Cardini per il cinquantesimo anniversario della morte Attilio Mordini, il Maestro dei segni, ed. Il Cerchio, Rimini 2017.
[7] Oscar Sanguinetti, Attilio Mordini di Selva, un ricordo, in “Cultura e Identità, rivista di studi conservatori” online, 16 (2021), pp. 9-14.
[8] Alessandro Staderini Busà, Attilio Mordini il “maestro” segreto, pubblicato su Il Quotidiano nazionale il 19 Giugno 2020.
[9] La vita e l’opera di San Francesco è l’argomento del suo Francesco e Chiara, pubblicato postumo nel 1986 dalle edizioni Cantagalli di Firenze a cura di Franco Cardini.
[10] Mordini, Il Tempio del Cristianesimo, p. 47.
[11] Tutto Il Tempio del Cristianesimo è dedicato da Mordini a questa sua concezione della storia.
[12] Mordini, Il Tempio del Cristianesimo, p. 10.
[13] Attilio Mordini, L’Arco in cielo, in “Il Ghibellino”, 7 (1961).
[14] Attilio Mordini, Azione aristocratica, in “Il Ghibellino”, 7 (1961).
[15] Attilio Mordini, Contemplazione e lavoro, in “L’Ultima”, 7 (1956).
[16] Si veda Mordini, Il Tempio del Cristianesimo, parte III Cultura e pseudocultura, pp. 147 e ss.
[17] Sul significato del teatro, che “dovrebbe più che divertire convertire”, si veda Attilio Mordini, Per una metafisica dello spettacolo, pubblicato in tedesco nella rivista “Antaios” nel 1965 e tradotto in italiano (postumo) in “Adveniat Regnum”, 7 (1968).
[18] Datato “29 settembre 1973, giorno di San Michele Arcangelo”, come è specificato in calce al ciclostilato, secondo l’antico modo di qualificare i giorni non con un numero privo di ogni significato se non meramente utilitaristico ma con il Santo del giorno.
[19] Attilio Mordini, Contemplazione e lavoro, in “L’Ultima”, 79 (1956), p. 85.
[20] Mordini, Il Tempio del Cristianesimo, p. 5.
[21] Mordini, Il Tempio del Cristianesimo, p. 194.
[22] Mordini, Il Tempio del Cristianesimo, p. 210.




